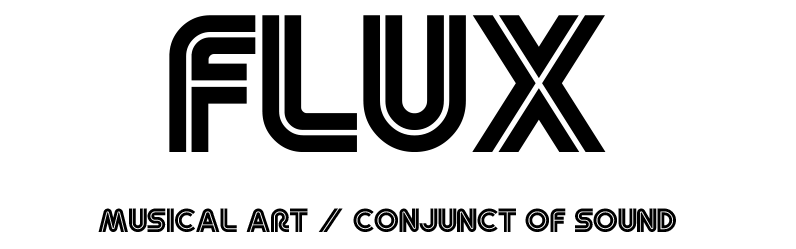Pubblicato da Alessandro Violante il aprile 5, 2015
 Il rituale è sempre quello: attendere anni per un loro album girando i forum di settore nei momenti liberi, poi ricevere la comunicazione del primo singolo, ascoltarlo per dire, così su due piedi, magari mentre si sta ascoltando tutt’altro, che tutto sommato non è male ma che non è sconvolgente. Poi comprarlo, ascoltarlo fino allo sfinimento e giungere alla conclusione che ci sono riusciti ancora, hanno prodotto ancora una volta un disco validissimo e fresco, poi il ciclo ricomincia.
Il rituale è sempre quello: attendere anni per un loro album girando i forum di settore nei momenti liberi, poi ricevere la comunicazione del primo singolo, ascoltarlo per dire, così su due piedi, magari mentre si sta ascoltando tutt’altro, che tutto sommato non è male ma che non è sconvolgente. Poi comprarlo, ascoltarlo fino allo sfinimento e giungere alla conclusione che ci sono riusciti ancora, hanno prodotto ancora una volta un disco validissimo e fresco, poi il ciclo ricomincia.
Ormai questo particolare artwork lo conoscete tutti, stiamo parlando di The day is my enemy del combo inglese The prodigy, che dal 1990 si è reso fotografia di quella scena elettronica successivamente nota con l’appellativo di big beat. Questo particolare ruolo nei confronti del mercato della musica ha sempre fatto sì che la loro identità non fosse riconducibile ad un vero e proprio genere con i suoi confini e le sue regole, ma che piuttosto fosse il veicolo attraverso il quale spiegare gli sviluppi della musica elettronica (e l’incontro tra elettronica, musica nera e punk) ad un pubblico ampio. Il concetto di big beat ha sempre cercato di trovare il punto di connessione tra vari generi ed estetiche solo apparentemente distanti tra loro: a modo proprio, ciascun protagonista di questo movimento ha interpretato il concetto di crossover tutto novantiano, ed è quello che ritroviamo anche oggi nei The Prodigy del 2015.
Dopo l’uscita di Invaders must die nel 2009 (ma questo è un esempio che vale per tutti i loro album), come accade di consueto, i fan si chiedono come suonerà il suo successore: in realtà nessuno lo sa, c’è chi fa ipotesi, ma lasciano sempre il tempo che trovano. I The Prodigy del 2015 sono un gruppo che, se vogliamo, è migliorato ulteriormente, ritrovando quella vena compositiva che sì, non si era mai esaurita, ma che aveva prodotto forse un paio di riempitivi nell’album precedente. Non è mica semplice, dopo venticinque lunghi anni di attività, confezionare almeno dieci-dodici potenziali hit singles su quattordici, nè tantomeno creare un disco di quattordici brani che non annoi o che non faccia pensare ad un “già sentito”.
Sì, i richiami al loro lavoro sono indubbi, sebbene piuttosto velati: Wild frontier è, concettualmente e musicalmente, vicina ad un brano come Narayan, così come Destroy ha, perlomeno ritmicamente, qualcosa di Smack my bitch up, e Rhythm bomb con i Flux pavilion (ma anche Get your fight on) ha qualcosa di Always outnumbered, never outgunned (per citare una manciata di esempi), ma, ancora una volta, Liam, Maxim e Keith hanno in mente qualcosa di diverso, anche se teorizzato già in passato. The day is my enemy è profondamente diverso dal suo predecessore, è più maturo: potrebbe essere immaginato, per usare una metafora, come una sorta di road movie, sin dalla produzione volutamente sporca e retro alla maniera di un ottimo film di Quentin Tarantino. Ecco, Tarantino, sì. Questo è un complimento se a te, ascoltatore, piacciono i suoni di brani come Hotride. Questo album è molto vintage, in tutti i sensi, eccone alcuni: il recupero della dimensione rave in certi suoni di synth anni ’90 (si pensi, a mo di esempio, alla titletrack), il recupero delle ritmiche d’n’b e, in generale, di tutte quelle ritmiche indissolubilmente legate ai generi nati negli anni ’90 ma, soprattutto, il recupero dell’incontro/scontro tra elettronica e punk che fece la fortuna di The fat of the land, seppure se ne discosti dal punto di vista estetico. Del resto, citazioni a parte, in qualità di inventori di una certa di idea di elettronica, ne hanno anche creato i confini di genere, ed è impensabile non utilizzarli anche oggi.
Sebbene recuperi tanto dell’elettronica degli anni ’90, si tratta di un lavoro che non si consuma tanto nei dancefloor, quanto nelle enormi strade sterrate statunitensi. E’ tutto un rombare del motore di una vecchia decappottabile, vento in faccia, odore di benzina e libertà. Basta la produzione a far capire cosa vuole ottenere Liam: quei dieci secondi iniziali sono rivelatori della direzione che ha voluto prendere: Invaders must die era l’anticipatore di un nuovo concetto di musica ballabile (quello che poi sarebbe esploso come fenomeno dubstep di massa), The day is my enemy si trascina con una voce effettata e dolce che ricorda quanto fatto in AONO.
Si prosegue poi per tredici brani in cui si alternano sporchi ritmi da road movie, contraddistinti da melodie altrettanto sporcate dalla polvere della strada sterrata che viene attraversata, si pensi a Nasty, dal sapore così fortemente americano che già recupera la chitarra, elemento predominante di questo lavoro così fisico e rock, a costruzioni electro-punk da pogo sfrenato ed estremamente groovy come Rebel radio e la critica del sistema Ibiza in Ibiza (in collaborazione con gli Sleaford mods), una cavalcata d ‘n‘ b diretta e intelligente, e ad episodi esplosivi, punk ed elettronici insieme, come la già citata Destroy o Wall of death, ideali per mettere in mostra i vocals propulsivi di Maxim e Keith. Anche Rok-weiler, uno dei brani più belli, rientra in quest’ultima categoria. Roadblox è un altro ottimo episodio che si discosta dagli altri e che offre una staccata tarantolata, veloce e dannatamente groovy.
The day is my enemy è però anche Beyond the deathray e Invisible sun, due episodi a sè stanti che evidenziano il calderone colmo fino all’orlo dal quale i nostri hanno attinto: cinematografica la prima, da tramonto nel deserto, silenziosa e caratterizzata dal synth acido e rovente, lenta scansione rock la seconda, che, ancora una volta, ci fa ripensare ad una passeggiata nel deserto, con i motori sempre pronti a rombare.
I The Prodigy sono sempre stati, e qui lo dimostrano a maggior ragione, un gruppo lontano dai dogmi, alfieri del crossover, con la stessa passione per i rave e l’evoluzione della musica elettronica, l’hip hop, la drum ‘n’ bass, il punk e, più in generale il rock. Un gruppo che, ancora oggi, a venticinque anni di distanza, può tranquillamente mettersi in cattedra e iniziare a spiegare. Non hanno inventato un genere particolare nè sono stati personaggi chiave per la sua evoluzione, ma hanno capito, meglio di tutti gli altri, come mettere insieme i vari pezzi del puzzle. Questo è il big beat, questi sono i The Prodigy.
Quello che, invece, non sono oggi i The Prodigy, sono un gruppo generazionale che, con un album come The fat of the land, rappresentava, invece, così come altri album di pari livello come Nevermind e altri, il sentimento di una generazione. Oggi si tratta di giudicare un gruppo ancora in grado di dire, e di farlo bene, molte cose, ma che corre sulla propria strada, il cui suono non è più la diretta espressione del sentimento provato dai giovani, ma una continua ricerca del groove perfetto, dell’onda perfetta da cavalcare. Si tratta di aspettare e vedere se questi nuovi brani riusciranno, nel lungo periodo, ad essere, in suono, quello che oggi la società sta provando. Si tratta di vedere se The day is my enemy avrà lo stesso potere di Smack my bitch up o di Smells like teen spirit di essere la diretta trasformazione della frustrazione giovanile.
Voto: 9
Label: Take me to the hospital, Cooking vinyl