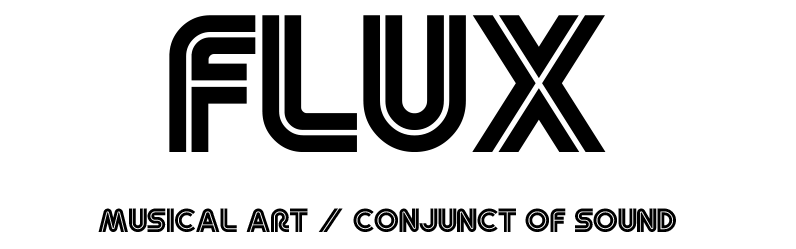Pubblicato da Alessandro Violante il novembre 22, 2014
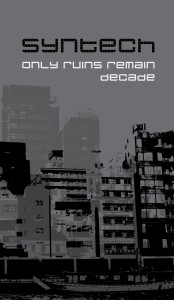 Un tempo era l’Inghilterra, oggi è la Germania. No, non è un luogo comune. Il breakbeat ha contraddistinto le sonorità di tante realtà early rave ed è stato elemento di primo piano nel fenomeno tutto inglese del big beat. Oggi ha fatto le valigie e ha cambiato casa. Ha scelto quella di Steffen Lehmann, in arte Syntech, che qui è al quarto disco, sempre per Hands productions.
Un tempo era l’Inghilterra, oggi è la Germania. No, non è un luogo comune. Il breakbeat ha contraddistinto le sonorità di tante realtà early rave ed è stato elemento di primo piano nel fenomeno tutto inglese del big beat. Oggi ha fatto le valigie e ha cambiato casa. Ha scelto quella di Steffen Lehmann, in arte Syntech, che qui è al quarto disco, sempre per Hands productions.
Only ruins remain è un brillante esempio di come sia possibile lavorare a tutto tondo con il ritmo spezzato, plasmando, a seconda dei casi, il diamante sulla base delle esigenze e del genere. Sebbene i campi di interesse siano molteplici, questi episodi possono essere racchiusi dentro la sigla breakbeat, spinto alla massima potenza. Intelligente alla maniera di Aphex Twin ma sicuramente molto più ispirato dell’ultimo, fiacco, Syro, e allo stesso tempo dirompente come una pioggia di sassi sporchi e squadrati su una città di cui sono rimaste solo le rovine.
Distopia? Forse. I Syntech sono i protagonisti di un’altra pagina di storia che deriva più che in parte dalla precedente, ovvero dall’epoca in cui, per rimanere in tema con quanto è uscito in questi giorni, i nuovi palazzi sono crollati. Ne è passata di acqua da allora, da quel Kollaps che contribuì ampiamente allo sviluppo del genere, ed allora ecco che, se i primi fanno riferimento ai palazzi, il secondo si concentra sulle rovine. Ancora una volta il dilemma è il seguente: da dove ricominciare? Cosa è possibile realizzare con quel poco che si ha? Tanti anni prima, in una famosa dichiarazione, Genesis P-Orridge disse che in fondo non aveva inventato chissà cosa perchè quei rumori, che insieme componevano quella sorta di sinfonia, esistevano già, allora ecco che viene in soccorso il ritmo afroamericano.
Tripudio del ritmo spezzato, Only ruins remain mette a nudo la crudezza del beat, aiutato da una produzione tutto fuorchè cristallina, e lo declina in quattordici brani che forse non avranno molto di pionieristico, ma che spesso fanno gridare al miracolo. Si parlava di Richard D. James. La opener Spindrift è un brano che ha non poche assonanze con il lavoro di un’icona degli anni ’90 come lui. Qui la formula è completata dall’utilizzo del sampling ferale che ce ne offre una versione incupita e molto ben concepita. Segue subito la titletrack con quel suo giro melodico da day after the storm inscatolato in un mid tempo di un dubstep pesante, e le distorsioni del beat rievocano il cantiere in cui si tenta di ricostruire dal basso.
Dopo due episodi pesanti come macigni che si trascinano lentamente fino a sommergere l’ascoltatore, ecco che il nostro comincia a pigiare sull’acceleratore. La differenza rispetto ad altri suoi colleghi, però, sta nel fatto che la cupezza dell’elettronica più oscura qui non trova luogo, a scapito del ritmo primitivo afroamericano con il quale viene costruito il breakbeat incessante ma sempre ragionato di Drive hunt. Aggiunte elettroniche gli danno ancora più forza e danno, se possibile, una forza ancora maggiore a Electric hellfire, nome che calza a pennello con quello che si ascolta, un’altra intricata sfuriata da manuale, qui maggiormente supportata dagli aiuti elettronici. Saluager è uno degli episodi più interessanti e più importanti con quel suo beat distorto che parte lento e che poi si lancia in una corsa in 4/4, una techno scura come la pece mescolata a breaks di ottima fattura.
For how long è un’altra stridente e primordiale cavalcata breakcore, e così anche la successiva Ignorance, più lenta e ragionata, che si regge su pesanti passi di elefante che ne costituiscono i confini. Il tappeto di fondo è, ancora una volta, grigio e distorto. Mutations è un altro brano techno sporcato dai breaks e da distorsioni, mentre Panic fa uso di un breakcore compresso e opprimente come nessun altro brano qui presente. La frenesia del ritmo non può non coinvolgere il corpo, spingendo a ballarlo.
Mirrors è un altro degli episodi migliori, retto su un ritmo semplice ma d’effetto: drum ‘n bass destrutturata alla maniera del primissimo Dive, ma meno cupa. Assolutamente coinvolgente e, ovviamente, infarcita dai soliti breaks di sottofondo che non guastano mai. Harvest season è un altro episodio techno-ish condito da campionamenti di rumori freddi come l’acciaio, con il solito sottofondo cacofonico sul quale si poggia la ritmica. Il motivo di pianoforte di Prospector chiude un album lungo ma mai noioso, sempre in grado di tenere molto alta l’attenzione dell’ascoltatore. L’ultimo brano è un breakbeat primordiale da rituale africano per la generazione delle macerie.
Un album che di perfettibile ha ben poco. L’ascolto è essenziale per chiunque ami la musica elettronica e le sue declinazioni spezzate.
Label: Hands productions
Voto: 9,5