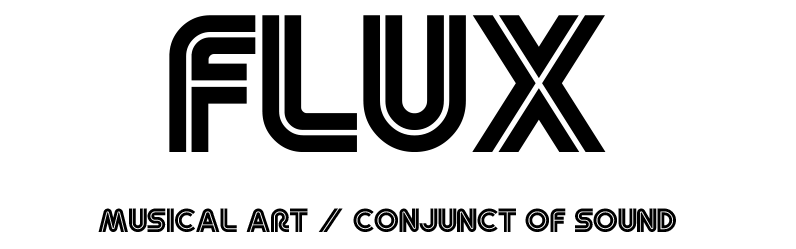Pubblicato da Alessandro Violante il marzo 24, 2015
 Quella in scena presso la Galleria Lia Rumma di Milano è la terza mostra monografica per un artista così spesso messo in secondo piano come lo statunitense Gary Hill, uno dei più noti artisti del video appartenenti alla seconda generazione, quella che inizia durante i primissimi anni ’70. Hill comincia a creare la sua arte in un momento storico-artistico in cui molti dei fondamenti della video arte monocanale erano già stati analizzati dagli artisti precedenti come Nam June Paik e da tutta la generazione dei primi artisti legati al discorso concettuale Experiments in arts and technology (il cui lavoro era stato ampiamente analizzato da Gene Youngblood), ma non per questo non è una figura particolarmente importante.
Quella in scena presso la Galleria Lia Rumma di Milano è la terza mostra monografica per un artista così spesso messo in secondo piano come lo statunitense Gary Hill, uno dei più noti artisti del video appartenenti alla seconda generazione, quella che inizia durante i primissimi anni ’70. Hill comincia a creare la sua arte in un momento storico-artistico in cui molti dei fondamenti della video arte monocanale erano già stati analizzati dagli artisti precedenti come Nam June Paik e da tutta la generazione dei primi artisti legati al discorso concettuale Experiments in arts and technology (il cui lavoro era stato ampiamente analizzato da Gene Youngblood), ma non per questo non è una figura particolarmente importante.
Hill vive da protagonista e collabora attivamente al passaggio o, per meglio dire, alla nuova forma di comunicazione tra monitor e bit, all’incontro della video arte analogica con il medium digitale. Nel 1973, infatti, Steina e Woody Vasulka danno alla luce uno dei loro lavori più importanti, Vocabulary, che ha in sè tutti i germi di quello che il video diventerà negli anni a seguire. Hill è un artista che si trova a contatto con una molteplicità di media e, quindi, di differenti linguaggi: è un artista proiettato verso il futuro di questa disciplina ma, allo stesso tempo, vive ancora, perlomeno inizialmente, in un’epoca in cui tutto era un po’ più artigianale e primordiale. Quel che l’artista mette in mostra a Milano è un mix del suo percorso artistico, trattasi soprattutto di lavori più recenti, che comunque evidenziano una poetica più vicina ai pionieri di questa forma artistica rispetto a molti artisti contemporanei, e questo è perfettamente comprensibile già nel momento in cui si entra nello spazio espositivo, che si sposa ottimamente con l’estetica artistica dello statunitense.
Hill sente, da un lato, la necessità di trasformare lo spazio attorno a sè in una dimensione a sè, in uno spazio artificiale che è quello della videoinstallazione, e dall’altro subisce la forte influenza dell’arte concettuale degli anni ’70, in particolare tramite la lettura e l’apprezzamento per gli scritti di Maurice Blanchot. L’arte di Hill è chiaramente processuale, si focalizza su quella comunicazione silenziosa che gli artisti di quegli anni inseguivano, richiede allo spettatore di ricoprire un ruolo chiave nella comunicazione col monitor (senza mai davvero invitarlo ad una benchè minima forma di interazione e, quando egli viene chiamato ad occupare quel ruolo, come non accade invece in Klein bottle, in cui viene chiamato ad osservare l’ingegnoso processo ongoing. Il video, nella sua estetica, non è interattivo nè descrittivo, ma è una comunicazione silenziosa, un processo in costante divenire, ed è il concetto sul quale Hill si sofferma.
Come in uno spazio cinematografico, aiutati da una sorta di atmosfera da buio in sala, il visitatore si trova ad entrare in punta di piedi in un ambiente minimalista (che ben si presta) e silenzioso, straniante e caratterizzato da una geometria forte. Il visitatore ha appunto un ruolo forte e viene spinto alla riflessione sulla natura concettuale / processuale del video già da Isolation tank, del 2014, mostrata esternamente solo durante il day one della mostra.
 Lo straniamento è forte nel primo ambiente, quello introduttivo, in cui ci si trova a vivere Choir box, questa pensata per lo spazio espositivo della Galleria, dissonante e concettuale. Questa dimensione concettuale / processuale viene ancor più enfatizzata nel primo piano, dove l’allestimento, tramite una forte enfasi sulla luce, mostra tre lavori: Learning curve (Still point) del 1993, Sine wave del 2011 e Klein bottle del 2014. Se quest’ultima, tramite il sapiente artificio geometrico della Bottiglia di Klein (una superficie per la quale non esiste alcuna differenza tra interno ed esterno), induce a pensare l’eterna comunicazione insita nella videoarte, la prima invita lo spettatore a diventare l’oggetto della risposta del monitor, quello che era in origine la videocamera, ed è uno dei lavori più emblematici e profondi della mostra. Il secondo è un altro lavoro profondo e mistico, che lascia lo spettatore constantemente in bilico tra mondo reale e virtuale, intendendo con ciò lo spazio del museo.
Lo straniamento è forte nel primo ambiente, quello introduttivo, in cui ci si trova a vivere Choir box, questa pensata per lo spazio espositivo della Galleria, dissonante e concettuale. Questa dimensione concettuale / processuale viene ancor più enfatizzata nel primo piano, dove l’allestimento, tramite una forte enfasi sulla luce, mostra tre lavori: Learning curve (Still point) del 1993, Sine wave del 2011 e Klein bottle del 2014. Se quest’ultima, tramite il sapiente artificio geometrico della Bottiglia di Klein (una superficie per la quale non esiste alcuna differenza tra interno ed esterno), induce a pensare l’eterna comunicazione insita nella videoarte, la prima invita lo spettatore a diventare l’oggetto della risposta del monitor, quello che era in origine la videocamera, ed è uno dei lavori più emblematici e profondi della mostra. Il secondo è un altro lavoro profondo e mistico, che lascia lo spettatore constantemente in bilico tra mondo reale e virtuale, intendendo con ciò lo spazio del museo.
Nel secondo piano, il buio in sala così come la tipologia di allestimento e le opere in mostra affrontano altre facce dell’artista poliedrico: la psichedelia e l’astrazione di Depth charge, un lavoro la cui gestazione è durata tre anni, un’opera che prende le mosse da un suo vecchio lavoro, Varese 360. L’astrazione data dall’utilizzo di tecniche legate alla sperimentazione del nuovo vocabolario dei già citati Vasulka, quella basata sulla manipolazione dell’immagine elettronica tramite il Rutt-etra scan processor, la componente psicotropa-allucinogena evidenziata dai video mostrati sui supporti, la musica suonata da Bill Frisel e da Varèse (la sua composizione Un grande sommeil noir del 1906) sono gli elementi chiave della videoinstallazione più importante (e, che non a caso, svetta tra le foto promozionali) di questa mostra monografica.
 Pacifier è un altro lavoro pregno di significato, uno spunto di riflessione sulla relazione ciucciotto dell’infante / bomba atomica, un lavoro che, nel suo incedere lento tutto giocato sull’esplosione del contatto, del climax, del passaggio tra uno stato e l’altro, ha tanto del Bill Viola degli ultimi vent’anni.
Pacifier è un altro lavoro pregno di significato, uno spunto di riflessione sulla relazione ciucciotto dell’infante / bomba atomica, un lavoro che, nel suo incedere lento tutto giocato sull’esplosione del contatto, del climax, del passaggio tra uno stato e l’altro, ha tanto del Bill Viola degli ultimi vent’anni.
Quella di Hill presso la Galleria Lia Rumma non è una mostra di immediata comprensione ma è l’occasione perfetta per scoprire l’operato di un artista che, pur essendo un nome storico del genere, non si adagia affatto sugli allori e, tra un ripescaggio e una nuova idea, è ancora capace di stupire grazie ad un allestimento studiato per esaltarne il trademark e grazie a idee mai banali. Quella di Hill è una mostra di videoarte nella sua accezione più classica, una occasione per tornare in contatto con l’opera in qualità di comunicanti, per scoprire cosa ci sia oltre la semplice visione dell’opera, per capire o, comunque, per ricordare a noi stessi la particolarità di questo linguaggio artistico e la dilatazione temporale della visione/percezione/comunicazione, la pazienza che si richiede all’osservatore attento, la dimensione quasi-spirituale che il video richiede, non a caso Paik ne fu il vero profeta estetico. Estasiati davanti ad una comunicazione silenziosa e accondiscendente, inseriti nello spazio della quarta dimensione, questo modo di vivere l’arte, anche grazie a Gary Hill, è ancora in grado di mostrare il suo indubbio fascino nell’u0mo del XXI secolo.