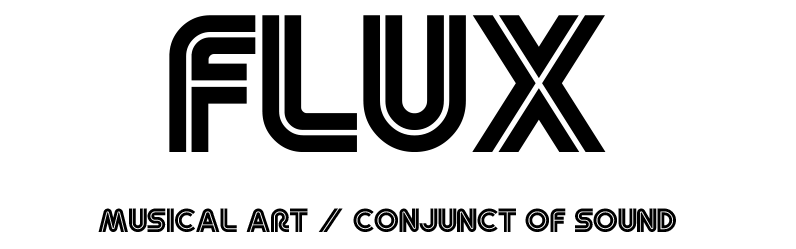Pubblicato da Alessandro Violante il marzo 25, 2016
 Come accade sempre più raramente, soprattutto nei nostri territori, visitando gli spazi espositivi della mostra Digital Flows (visitabile dal 5 marzo al 3 aprile, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 18.00), curata dalla piattaforma di videoarte milanese Visualcontainer (formata da Alessandra Arnò e da Paolo Simoni) ed ospitata all’interno degli spazi del MACT / CACT di Bellinzona, sembra di tornare indietro nel tempo, di recuperare una dimensione fruitivo-esperienziale dell’opera videoartistica che troppo spesso sembra oggi relegata ai libri di storia, in favore di quell’approccio puramente narrativo al linguaggio artistico che sembra dominare manifestazioni (non tutte, questo è certo) e mostre di vario genere, in particolar modo quelle di alcuni artisti che sembrano più interessati ad una concezione di videoarte più simile a quella cinematografica. Questo nasconde, però, le enormi (e ben lontane dall’essere esaurite) potenzialità di questa forma d’arte.
Come accade sempre più raramente, soprattutto nei nostri territori, visitando gli spazi espositivi della mostra Digital Flows (visitabile dal 5 marzo al 3 aprile, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 18.00), curata dalla piattaforma di videoarte milanese Visualcontainer (formata da Alessandra Arnò e da Paolo Simoni) ed ospitata all’interno degli spazi del MACT / CACT di Bellinzona, sembra di tornare indietro nel tempo, di recuperare una dimensione fruitivo-esperienziale dell’opera videoartistica che troppo spesso sembra oggi relegata ai libri di storia, in favore di quell’approccio puramente narrativo al linguaggio artistico che sembra dominare manifestazioni (non tutte, questo è certo) e mostre di vario genere, in particolar modo quelle di alcuni artisti che sembrano più interessati ad una concezione di videoarte più simile a quella cinematografica. Questo nasconde, però, le enormi (e ben lontane dall’essere esaurite) potenzialità di questa forma d’arte.
Soprattutto durante i tardi anni ’60 e i ’70, sino, indicativamente, alla metà degli anni ’80, molti sono stati quegli artisti che, spesso in congiunzione con ingegneri e tecnici di vario genere, hanno dato forma e sostanza alla loro creatività e a loro pensiero, talvolta, come nel caso di Steina e Woody Vasulka o Lynn Hershman Leeson tra gli altri, rivestendo un ruolo di primissimo piano non solo nell’evoluzione della forma d’arte in sé, ma anche in quella della tecnologia, avvalendosi, come nel caso dei Vasulka, di supporti (che oggi chiameremmo devices) particolarmente all’avanguardia, dei cui frutti, consciamente o inconsciamente, godiamo anche oggi, e sono stati tra le influenze principali di chi, in quegli stessi anni, cominciava ad operare nel campo della new media art, artisti che, in non pochi casi, hanno anticipato alcuni sviluppi del nostro futuro (si legga al proposito l’intervista a Monika Fleischmann e Wolfgang Strauss in FLUXES #2).
Si recupera, con Digital Flows, il concetto di flusso digitale, di tempo non-cinematografico, come teorizzato da Woody Vasulka, ma piuttosto di tempo dell’immagine prima analogica e poi digitale, del tempo “reale”, modificabile in real time in qualsiasi momento (per mezzo della tecnica nota come feedback), sebbene i lavori fruibili siano video digitali il cui ciclo di vita è stato già scritto ed è immutabile.
Nel caso di Euphoria del sudcoreano (non è un caso) / statunitense Hwayong Jung, la cosiddetta generative art, una sorta di corrente trasversale rispetto alla video art digitale, recupera, grazie ai frattali generati casualmente da un algoritmo definito dall’artista, lo spazio non-cinematografico, il cosiddetto video void di David Larcher, un’astrazione dal reale che genera in noi una riflessione e l’entrata in una dimensione altra, che poi è una delle caratteristiche più affascinanti del video d’artista e della videoarte in generale.
L’italiana Barbara Brugola, in Lapse Of View, flirta con il medium cinematografico, ricorrendo a tecniche utilizzate anche da cineasti di matrice sperimentale (seppur sempre con un occhio rivolto alla dimensione narrativa del cinema) come Peter Greenaway, e in questo lavoro gioca con il tempo e le dimensioni contrapposte. C’è anche qui un focus sul medium, piuttosto che sulla narrazione, in un’ottica molto vicina a quella dei padri del linguaggio.
Gianluca Abbate, in Panorama, se artisticamente si lega al lavoro di artisti più recenti, concettualmente riprende il mai tramontato sogno della visione panoramica che, con le manifestazioni della virtual art degli anni ’90, ha conosciuto alcune delle sue espressioni più felici. Qui l’artista non si concentra tanto su un’immersione sensoriale quanto su una spinta alla riflessione sul mondo che ci circonda e sul rapporto tra natura e sviluppo urbano / tecnologia, fotografando molto bene le apparenti contraddizioni tipiche della nostra società (alle quali siamo ormai abituati).
Il lituano Rimas Sakalauskas, in Synchronisation, lavora non tanto sull’astrazione concettuale quanto sull’ibridazione tra scenari presi dalla realtà ed elaborazioni postprodotte che creano un effetto anomalo e difficile da comprendere a prima vista. Per usare termini adatti agli sviluppi artistici dei nostri giorni, l’artista qui lavora sull’aumento della realtà e sullo slegamento, dal contesto, di elementi degli scenari mostrati. Qui è straniante la scelta di utilizzare dei tempi molto lunghi, che sembrano rappresentare la lenta liberazione da un peso che ci attanaglia, e ci si sente quasi sollevati quando questi elementi abbandonano lo spazio dell’opera.
System dello spagnolo Miguel Andres è un video che ci fa, piuttosto chiaramente, riflettere sulla condizione dell’uomo postmoderno programmato da una società che gli impone predeterminati modi di pensare e di agire nei confronti del mondo, riprendendo in mano il mai troppo scandagliato universo concettuale del Matrix dei fratelli Wachowski. Un lavoro breve ma intenso.
C’è poi il lavoro dell’austriaca Katharina Gruzei, dal titolo Workers Leaving The Factory (Again), che da un lato paga un ovvio tributo al celeberrimo “film” dei fratelli Lumière, che tanto scalpore destò nel pubblico della fine del XIX° secolo, e dall’altro ha un legame con Il Quarto Stato di Pellizza Da Volpedo. Qui viene evocata la dimensione alienante del capitalismo più estremo che ci vuole macchine prive di identità, unicamente votate alla produzione di prodotti che, nella maggior parte dei casi, hanno vita breve e non ci apportano un concreto beneficio, accrescendo unicamente le nostre tasche. In questo lavoro, le fredde luci intermittenti sembrano quasi disegnare un pattern musicale avanguardistico e particolarmente straniante, degna conclusione del percorso espositivo di una mostra davvero fuori dai canoni odierni.
Vengono poi mostrati due lavori piuttosto anomali, ma che sono molto moderni nel loro fare uso di devices che utilizziamo quotidianamente. E’ questo il caso del kafkiano Scarabocchio di Marta Robelli, che, su una sorta di tablet, mostra la costante e nervosa mutazione tra uomo e insetto, ricorrendo ad una tecnica piuttosto semplice ma particolarmente efficace e d’effetto. L’ultimo lavoro è Pixel Motion, in coppia con Quaderno Di Colori, dell’italo-tedesca Cristina Ohlmer, un lavoro che unisce un video digitale ad un quaderno di esercizi, che l’artista ha dovuto utilizzare per risolvere un problema alla vista. La griglia formata da tanti piccoli quadrati colorati minuziosamente dall’artista è anche la griglia dei pixel visibile nel video.
Quel che è evidente al termine della visita della mostra è lo stretto legame che accomuna lavori apparentemente molto diversi tra loro, legati dall’interesse di recuperare la ricerca sul medium del video, piuttosto che sulla sua declinazione narrativa, allo scopo di spingere nuovamente il fruitore a vivere una esperienza totalizzante e, soprattutto, allo scopo di generare in lui una profonda riflessione sulla nostra condizione di uomini e donne e sui meccanismi che regolano la nostra epoca. Digital Flows è, inoltre, e questo non riveste certo importanza minore, un tentativo di riesumare il carattere distintivo del linguaggio artistico della videoarte, che lo rende ancora particolarmente affascinante e ricco di prospettive future. Staremo a vedere se il flusso digitale tornerà a fluire liberamente fuori dai confini cinematografici, anche grazie ai coraggiosi ragazzi di Visualcontainer. Una mostra da visitare.
Link utili: