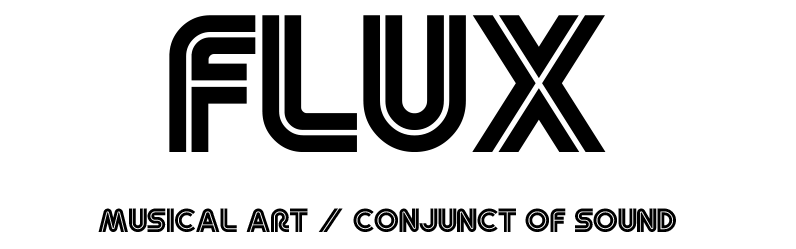Pubblicato da Davide Pappalardo il febbraio 19, 2016
 L’inglese Colossloth lascia una scia di mistero dietro di sé in un’epoca in cui questo, grazie ad Internet, è sempre più difficile, data la facilità con la quale si possono reperire informazioni quasi su tutti; proveniente dalla contea del Leicestershire, il Nostro non diffonde il suo nome, anche se sue diverse foto sono apertamente visibili su vari siti e video dal vivo, facendo parlare la sua musica, la quale viene posta al centro dell’attenzione.
L’inglese Colossloth lascia una scia di mistero dietro di sé in un’epoca in cui questo, grazie ad Internet, è sempre più difficile, data la facilità con la quale si possono reperire informazioni quasi su tutti; proveniente dalla contea del Leicestershire, il Nostro non diffonde il suo nome, anche se sue diverse foto sono apertamente visibili su vari siti e video dal vivo, facendo parlare la sua musica, la quale viene posta al centro dell’attenzione.
Egli ha all’attivo alcuni lavori indipendenti tra cui la tape Black Mermaid / A Circle Of Thrones per l’americana Scumbag Relations, il CDr Torn By The Black Talons Of God per la belga Bone Structure, il vinile Antipathy In Nature per l’americana Doom-Mantra Records, nonché diversi EP digitali, i quali hanno creato una certa fama tra i cultori dell’elettronica sperimentale grazie ai suoi connotati tribali e doom (in senso più lato rispetto alla valenza prettamente rock / metal del termine), espressi in un drone ipnotico in cui suoni moderni e tendenze ataviche trovano felice connubio.
Ora il Nostro esordisce per la storica etichetta inglese Cold Spring con l’album Outstretch your hand for the impress of truth, opera qui recensita, un lavoro di elettronica tribale in cui parti dark ambient si uniscono a soluzioni tecnologiche dagli elementi noise, feedback e drone mai troppo ostici (almeno per chi è già familiare con il genere), messi al servizio del rituale sonoro da lui orchestrato; il risultato è qualcosa che riesce ad essere legato ad una certa tradizione sperimentale tra lo-fi ed ambientazioni sonore, ma anche non anacronistico e memore delle evoluzioni odierne e dell’epoca in cui siamo. Nove episodi che riservano anche qualche sorpresa ben orchestrata, per un disco che richiede un ascolto attento, immersi possibilmente al buio nel mondo da esso evocato; riverberi, suoni di piano, alcuni elementi acustici, sommessi e distanti campionamenti vocali completano il quadro di un’opera che può dare molto all’ascoltatore.
Viene da sé che qui è la totalità ad essere importante, pur senza togliere identità ai singoli episodi, tappe di un percorso complessivo che ci conduce in territori interiori prima forse sconosciuti; The flavour of the weak è la partenza caratterizzata da strati dark ambient presto sconvolti da alcune scariche nervose ed arpeggi campionati, elementi presto raggiunti da fraseggi grevi, effetti sinistri e loop ossessivi. Potrebbe sembrare di trovarci davanti ad un episodio di drone “standard”, ma ecco che al minuto e quarantasei le carte in tavola cambiano grazie a distorsioni noise che prendono posto in una “cacofonia tecnologica” protratta a lungo; largo poi alla ripresa del mantra iniziale fino alla conclusione in un finale che si ricollega all’inizio.
Your flag stands for nothing punta invece sin dall’inizio su pesanti e distorti colpi pachidermici, in una sorta di “pressa digitale” in cui, sull’andamento monolitico, trovano posto synth stridenti; segue poi l’intervento di linee evocative e suoni di corni dall’impianto ambientale, ancora una volta generando quella sovrapposizione di strati che fa evolvere il pezzo. Al minuto e trentasette un feedback improvviso interrompe il tutto, lasciando posto ad un crescendo di archi e suoni orchestrali; non dobbiamo però farci ingannare, in quanto le distorsioni iniziali tornano presto sulla scena, chiudendo il cerchio anche in questo caso.
Cave in we are complete torna sui toni ambientali ed evocativi, creando immagini sonore degne di un Lustmord meno infernale; s’intersecano qui squillanti suoni meccanici e fischi, tra atavico e futuro. Alcuni riff in loop compaiono nella struttura, accompagnando poi una serie di distorsioni in un caotico crescendo, ma, come spesso accade con il Progetto, il songwriting non segue una trama temporale regolare, ed ecco che, all’improvviso, oscillazioni drone prendono posto insieme a suoni in reverse in un mantra in cui le tendenze dark ambient iniziali trovano nuovamente spazio, prima della conclusiva cacofonia e degli effetti robotici in chiusura.
la title track si espande tra arpeggi e suoni sommessi, fino alla partenza di distorsioni e movimenti da segheria di matrice industriale; al minuto e sedici tutto si blocca, lasciando spazio ad effetti in reverse ai quali seguono interferenze come da radio, in una sorta di inno da “rock da stadio” frammentato e decontestualizzato. E’ in occasioni come questa che si mostra il genio del Nostro, capace di manipolare la materia sonora e non in modi non scontati; si riprende, quindi, con i disturbi da musica concreta, scemando poi nel motivo iniziale, che degenera in una punta oscura che chiude il brano.
The world keeps turning (on me) ci mostra inquietudini ambientali e sferraglianti suoni elettronici che salgono d’intensità fino all’incontro con distorsioni aliene e caustici riff campionati; una colonna sonora che s’impreziosisce con strati di organo ripetuti in un rituale che collima con il ritorno dei riff “a motosega”, in una cesura doom ancora una volta raggiunta da cacofonie stridenti. La chiusura è affidata agli effetti vorticanti, dando degno finale a questo pastiche post-industriale.
Of talons and teeth parte con feedback squillanti che vengono raggiunti da scariche distorte di chitarra in una marcia severa, a cui seguono melodie in loop che si sovrastano al tutto, fino all’improvviso passaggio a parti eteree che si legano a temi epocali in lo-fi che però non hanno lunga vita, presto sostituiti da distorsioni ritmate con una certa sorprendente musicalità; loop vocali pesantemente effettati hanno qui casa, creando una sequenza ipnotica. Il finale, come di consueto, è una chiusura del cerchio, con un ritorno ai feedback e ai riff ripetuti; un’altra composizione basata su una sequela di elementi alternati e ben orchestrati.
Paint her face to simulate the bloom si manifesta in forma dark ambient prima di aggiungere interferenze sibilanti dal gusto digital-noise, unendo, ancora una volta, la tradizione del genere con derive più moderne; effetti da field-recording prendono poi posto insieme a tasti di pianoforte che creano una composizione classica sovrastata da disturbi, che tornano poi padroni in un drone inumano in cui a dominare è la fabbrica; la conclusione non può che rimandarci alle ambientazioni iniziali, lasciandoci esterrefatti.
The nameless saint ci sorprende con l’elemento pianistico in apertura, successivamente unito a taglienti effetti stridenti, in una sorta di orchestrazione futurista; raggelanti assoli distorti si uniscono con il loro suono da ciminiera, aumentando l’idea di un concerto per macchine e non umani. Effetti noise completano il quadro, portandoci al minuto e cinquantacinque; qui, prendono il sopravvento tra ritmiche dub dal gusto tribale, in un cambio di registro che però non è eterno, lasciando presto posto anche ai tasti del pianoforte, che tornano padroni nella conclusione.
Black deeds from dead seeds indulge nel gioco di synth minimali ed effetti ambientali dal gusto caustico, in una serie di rimandi tra loop protratti ed interferenze; accenni acustici s’intromettono, riportando anche l’aspetto umano in quello che altrimenti sarebbe un rituale da pura fabbrica. Campionamenti vocali in reverse si affacciano mentre gli elementi portanti si ripetono in un drone etnico che prosegue senza grossi cambiamenti fino alla conclusione; forse l’episodio più “standard” del lotto, ma, non certo per questo, da disprezzare.
Un lavoro molto particolare che non segue, come molti, la linea tracciata dai colossi del noise, del drone, del dark ambient e del death / black industrial, cercando, invece, una propria strada; non abbiamo qui un’osticità intesa nel senso di pesantezza estrema o ossessione monolitica, e anzi molti tratti risultano molto “musicali”, pur non mancando un substrato sinistro che aleggia sul tutto, che per assurdo, però, può risultare ancora più difficile da digerire a causa di quell’unione tra movimenti atavici e rituali, parti acustiche, riff pesantemente distorti e suoni tecnologici da era digitale; certo, tutto questo non è propriamente inedito, ma se spesso in altri gruppi si traduce in una dimensione vicina alla danza (si pensi ai This Morn’ Omina e alle loro inflessioni trance) qui, invece, si mantiene su un piano sperimentale e meditativo dai tempi dilatati e spesso rallentati.
In un periodo in cui, purtroppo, l’elettronica sperimentale tradisce il suo nome e diventa spesso conforme a standard stabiliti, un’opera del genere non può che fare piacere; come anticipato, l’ascolto distratto è deleterio, ed è richiesta qui una serena, ma attenta, partecipazione alle suite e ai cambiamenti improvvisi. Per quanto ci riguarda, si tratta di un disco da premiare e da far conoscere; se siete in vena di ascolti diversi e meditativi, senza rinunciare ad una certa tensione sottintesa, qui avrete pane per i vostri denti.
Voto: 9
Label: Cold Spring